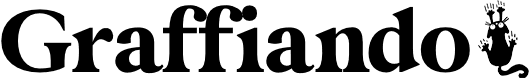Terzo appuntamento questa sera alle 19 per la VII edizione del Festival di Musica da Camera del Conservatorio “G.Martucci” tra Dvoràk e Beethoven. Domani quarta giornata con riflettori sul clarinetto.
di OLGA CHIEFFI
Continuano i concerti nella Chiesa di Santa Apollonia, nell’ambito della VII edizione del Festival da camera organizzato dal Conservatorio “G.Martucci”, dopo le prime due giornate che hanno ricevuto un ottimo riscontro di critica e pubblico. La coordinatrice della rassegna Michela Trovajoli, proporrà questa sera, con inizio all’abituale orario delle 19, il Piano Trio n°4 “Dumky” op.90 in Mi Minore composto da un Antonin Dvoràk, affidato al violino di Mariateresa Nappo, al cello di Alessia Mingo e al pianoforte di Aldo Pessolano. Già dal suo nome possiamo dedurre con una certa chiarezza le idee e le ispirazioni del compositore, così intensamente permeato di atmosfere ed espressioni popolari natie. La dumka è una forma-composizione-canto di derivazione ucraina dai tratti profondamente malinconici e contemplativi – non a caso il termine significa proprio “riflettere” – sovente scritta in tonalità minore e con tono elegiaco. Nel caso di Dvorak essa si avvicina molto alla czarda ungherese, nella quale tra i vari episodi mesti si intercalano momenti decisamente più frizzanti o leggeri, quasi sempre di ispirazione danzata. Il Trio “Dumky” è formato quindi da sei brani variamente combinati. Eppure, in ogni dumka il lato più triste tocca corde diverse, passando dal patetico al dolcemente abbandonato, dal teso al nostalgico, evocando un vero e proprio senso di distanza, di lontananza sia in termini di spazio che di tempo. La terza giornata sarà chiusa dall’esecuzione del Piano trio n°5 Spettri op.70 in re maggiore n°1 di Ludwig Van Beethoven, con Carmen Senatore al violino, Alessia Mingo al cello e Giovanna Basile al pianoforte. Apparizioni, fantasmi, visioni sono al centro dell’opera, così titolata da Carl Czerny, ex allievo del compositore, riguardo allo straordinario Largo assai ed espressivo. Solo in seguito si scoprì che in effetti Beethoven aveva utilizzato per questa pagina degli appunti composti inizialmente per il coro delle streghe di un’opera mai completata ispirata al Macbeth. L’apertura dell’Allegro stupisce per compattezza: i due temi principali – uno robusto e marziale e l’altro più cantabile – compaiono uno di seguito all’altro, in un esordio memorabile. Gli strumenti sono ormai trattati da Beethoven con perfetta uguaglianza e, nello sviluppo, il gioco contrappuntistico diviene il principale motore dell’azione.
Nel Largo assai ed espressivo i “viaggi” del pianoforte lungo tutta l’ampiezza della tastiera generano un’atmosfera umbratile, su cui si appoggiano gli archi, prima sottovoce poi in un canto malinconico e struggente. Con il tema incisivo del Presto finale le ombre svaniscono e torna a splendere il sole. Clarinetto Uber alles il 14 ottobre, una serata che verrà aperta dal clarinettista Francesco Pio Ferrentino, in trio con il cellista Matteo Parisi e il pianista Alessandro Amendola, con l’esecuzione del Trio in La minore composto da Johannes Brahms op.114, datato 1891, un omaggio al clarinettista Richard Muhefeld. La pagina si distingue per la sua libertà formale e, ancor più, per il suo peculiare “colore”, dovuto al timbro caldo e vellutato del clarinetto, impiegato con felice idiomaticità, e del cello, una “tinta” sostanzialmente autunnale e vespertina, ulteriormente evidenziata da un’invenzione melodica introversa e malinconica. Ciò è evidente sin dall’Allegro iniziale, armonicamente vivace e caratterizzato da una spigliata ritmicità, qua e là stemperata in alcuni passaggi cantabili del clarinetto. L’Adagio è intriso di intimismo tipicamente brahmsiano e di soffusa malinconia, ubbidiente ad una linea melodica di assorta e pensosa riflessione sulla caducità della vita. Di tono più delicato e pastoso nell’amalgama dei timbri fra i tre strumenti è l’Andantino grazioso, mentre l’Allegro conclusivo, disegnato con freschezza ed eleganza di immagini, mostra una esplicita naturalezza di espressioni, dai colori morbidi come di una tela dipinta ad acquarello, e senza alcuna ricerca virtuosistica fine a se stessa.
Seguiranno di Max Bruch tre pagine, la seconda, la quarta e la sesta, tratte dagli otto pezzi op.83 con interpetri Gaetano Apicella al clarinetto, Matteo Parisi al cello e Giovanna Basile al pianoforte. L’influenza di Brahms emerge chiaramente nel secondo Pezzo in si minore (Allegro con moto), pagina tempestosa, irrequieta, che si calma solo nelle battute finali, in tonalità maggiore. Pezzo cupo e trascinante (soprattutto per i disegni del pianoforte) è anche il Quarto (Allegro agitato), che pure trova un’illuminazione inattesa nel passaggio finale dal re minore al re maggiore, mentre Nachtgesang (Notturno) sarà la sesta miniatura, un Andante con moto in sol minore, innervato da un’ampia e delicata arcata melodica, disegnata prima dal solo clarinetto, poi anche dal cello. Omaggio a Gian Carlo Menotti da parte della violinista Angela Cardinali in formazione con Francesco Pio Ferrentino al clarinetto e Alessandro Amendola al pianoforte di rarissima esecuzione, che sfrutta al meglio le potenzialità espressive di questa formazione, individuando un carattere peculiare e ben differenziato per il violino e il clarinetto, con un’ironia e una leggerezza che cattureranno il pubblico in sala. Qualche parola in più si deve spendere, invece, il Trio, di Nino Rota, con al flauto Andrea Maddalena, Tommaso Troisi al violino e Alessandro Amendola al pianoforte, un autore di cui molto si sa e si apprezza, per quanto riguarda la sua produzione di musiche per il cinema. Questo è brano, datato 1958, composto per lo svizzero-cubano Trio Klemm un lavoro particolare, dotato di un’incisiva scrittura ritmica e trascoloranti ambiguità armoniche, interamente sorretto da una scrittura pianistica nervosa e brillante, mentre il flauto e il violino sono impegnati in soluzioni ritmico-melodiche di singolare spigolosità, come le note strappate del violino all’inizio dell’Allegro ma non troppo, predominanti nei due movimenti estremi.