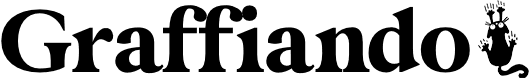Il mago della luce, da “Il conformista” a “L’ultimo Imperatore”, sarà questa sera ospite d’ onore della XXXV edizione del Premio Charlot. “le muse sono dieci e il cinema, l’ultima, le comprende tutte”
di OLGA CHIEFFI
Non predichiamolo, stasera, quale direttore della fotografia, quando salirà sul palcoscenico della XXXV edizione del Premio Charlot, ma creatore, della “foto-grafia” cioè dello “scrivere con la luce”, ovvero coautore dell’immagine insieme al regista. E’ giusto questo Vittorio Storaro, il quale sarà ospite di Claudio Tortora, in una speciale serata titolata “Emozioni” e che avrà quale ospite d’ onore il “visionario” dell’arte della luce, tre volte vincitore dell’Oscar ai David di Donatello, i premi BAFTA, i premi Goya. Lo abbiamo raggiunto alla vigilia dell’evento che questa sera lo vedrà protagonista all’Arena del mare.
Cosa è per lei la Fotografia?
Non ho mai accettato il predicato “direttore della fotografia”. Chi fa questo mestiere è co-autore dell’opera cinematografica, responsabile delle sue ideazioni. Il film è un’opera a più mani realizzata da una serie di co-autori e diretta dall’autore principale, che è il regista. Foto-grafia è etimotologicamente scrittura con la luce. Chi fa foto-grafia scrive con la luce la storia del film, come il compositore la scrive con le note, lo sceneggiatore con le parole. Il linguaggio della luce, e quindi di tutti i suoi componenti, ha una sua potenzialità, può esprimere sentimenti, emozioni, esattamente come le note di uno spartito o le battute di una sceneggiatura. Noi siamo dei visionari, deriviamo da una serie di visioni. Se un pittore racconta una storia in un’unica immagine – e anche per la fotografia pura e semplice è così – la cinemato-grafia, ed è questa l’espressione in cui maggiormente mi riconosco, ha invece qualcosa di più: il movimento, il ritmo. Quindi, scrivere con la luce è raccontare una storia cinemato-grafica attraverso la luce e tutti i suoi componenti. D’altro canto in orchestra è uno il direttore che dirige e nel film è il regista. Poi, ci sono le prime parti, il KonzertMeister, il primo violino, e nel film, in inglese mi faccio chiamare cinematographer e non dop (director of photography), in italiano “autore della fotografia cinematografica”. Il termine corretto sarebbe cinematografo, se non fosse che i nostri nonni, a un certo punto, hanno cominciato a dire “andiamo al cinematografo”, sbagliando, poiché “grafo” non indica un luogo ma una persona: il cinematografo sarei io, che scrivo con la luce in movimento e non il luogo”.
Quale segreto nasconde la leggendaria luce di Storaro?
“Alla base della mia visione di luce c’è quella di Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio. L’incontro avvenne nel corso di una passeggiata romana nel ‘68, con mia moglie. Io entro nelle chiese per goderne le geometrie, la luce, i colori, e in una di queste vidi tanta gente che guardava in alto. Ero nella chiesa di Santa Maria dei Francesi e davanti avevo la Vocazione di San Matteo: avevo studiato fotografia e cinematografia, eppure nessuno a scuola mi aveva mai parlato di Caravaggio. Ed ecco la lucida teoria delle forme sottratte al contingente, in virtù di una loro sofferta conquista dell’essenza delle cose, della loro dimensione ontologica. Il reale è come evocato, non rimosso ma sospeso, e in questa elegia del silenzio più alta si leva la voce dell’Uomo, la sua libertà. Caravaggio tagliava uno spazio della realtà, quasi una dimensione interiore e componeva un’immagine come cerco di fare io con la cinepresa. Naturalmente, parto dallo studio della sceneggiatura, quindi, attraverso l’ispirazione che viene dal mio personale background che comprende musica, filosofia, pittura, scultura, letture, presento la mia visione di luce al regista, il mio progetto da co-autore, si discute, si adatta e se accettato si realizza”.
La scena filmica a lei più cara in cui sente di aver realizzato tutte le sue ideali ragioni estetiche?
“Ho esordito con Franco Rossi in “Giovinezza, giovinezza” poi ho lavorato coi maestri del teatro e del cinema italiano Ronconi, Patroni Griffi, Bazzoni, Montaldo e su tutti Bertolucci. Quando mi ha chiamato Francis Coppola per Apocalypse Now, sinceramente ho rifiutato, sulle prime. Mi sono chiesto cosa mai avessi dovuto inventare per un film di guerra, quando venivo da film quali “Il conformista”, fatto di ombre, penombre, sfumature. Poi, ho parlato con Coppola e ho scoperto che la sua idea era quella di fare un film sulla civilizzazione, sul rispetto e sulla sopraffazione delle diverse culture, che nel corso dei Millenni è avvenuto quasi sempre attraverso la guerra. Sa bene che Apocalypse now è il riadattamento di “Heart of Darkness”, di Conrad, che ambienta le vicende di Charles Marlow durante la Guerra del Vietnam. La cosa più difficile era rendere l’entrata del misterioso Kurtz, interpetrato da Marlon Brando, che proprio per questo intoppo stava per rinunciare al film. Tre giorni di fermo le riprese per questo ostacolo, al quale pensavo notte e giorno. Il mito della caverna di Platone mi ispirò. Associai la caverna al cinema, infatti, nel mito, si racconta che, sin dall’ infanzia, degli uomini vivono incatenati, seduti a terra e con lo sguardo fisso rivolto esclusivamente verso una parete della caverna (lo schermo), su questa, grazie ad un immenso fuoco posto alle loro spalle (il proiettore), si riflettono ombre che riproducono oggetti (piccole statue di animali, persone e altro) tenuti in mano da altri uomini, nascosti dietro un muretto che divide il fuoco dagli uomini prigionieri. Quindi il fuoco riflette ombre di realtà fisiche che sembrano cullare ed intrattenere la vita dei prigionieri ma che, invece, intrappolano sempre di più i loro respiri e sguardi: sono esistenze svuotate, fisse su di un muro di ombre che li distrae dall’uso del loro pensiero. Krutz sarebbe stato l’uomo che esce dalla caverna. Proposi di farlo uscire un pezzo per volta dall’oscurità. Gli sono stato vicino e con una bandiera lo aiutavo a capire quando stava per uscire dal buio. La verità della storia, l’orrore della guerra, che esce pezzo dopo pezzo, per riconquistare l’umanità. Girai questa scena, prima da solo e convinsi Francis a visionarla con l’aiuto della sua Eleonore. Marlon Brando ebbe l’intuizione e da par suo interpretò quella scena come oggi la vedete”.
Il suo percorso dietro la macchina, il rapporto con il mezzo per fare arte?
“A scuola si impara la tecnica. Il colore l’ho scoperto a Parigi. Ma la visione, il segno personale lo trovi dentro te stesso. Il percorso è infinito, il demone, la passione deve bruciare tutta la giornata. Durante la lavorazione del film appunto Apocalypse Now le riprese, per incidenti vari, restarono ferme per tre settimane, tornammo tutti a casa, ma non vedevo l’ora che venissi richiamato e finire l’opera”. Le muse sono dieci e quella del cinema, la decima, racchiude tutte le altre. Per fare bene bisogna riempire il proprio contenitore e attingervi per avere e comunicare sempre nuove folgorazioni, visioni….”
Progetti a breve scadenza?
“Un volume dove scrivo, dopo tanti saggi, anche tecnici, in prima persona dei cinquant’anni di lavoro fra me e Bernardo Bertolucci e, soprattutto, il restauro dei nove film, partito nel 2020, girati con lui, Strategia del ragno, Il conformista, Ultimo tango a Parigi, Novecento atto I e II, La Luna, L’ultimo imperatore, Il tè nel deserto, Piccolo Buddha, attraverso nuove tecnologie per ridonare la tonalità dei sogni e delle visioni condivise con il grande regista e donarle gratuitamente a chi vorrà vedere le pellicole, in particolare agli studenti di tutti gli istituti”.