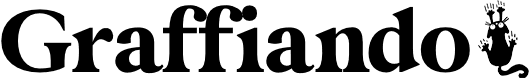Il soprano salernitano star all’Opera di Stato di Ruse in Bulgaria. Dopo aver debuttato nel ruolo di Liù in Turandot, il 21 novembre nella Sala Europa darà un récital dedicato alla canzone classica partenopea. Sul podio il Maestro Luca Gaeta che ha firmato anche gli arrangiamenti
di OLGA CHIEFFI
Dopo aver elevato il canto tenero di Liù, che accarezza il bamboleggiare dei toni interi, con donazioni più intense, l’unica pietas consapevole che l’opera Turandot conosca, Annalisa D’Agosto, continuerà il 21 novembre, dopo l’applaudito debutto, forse nel più umano dei ruoli pucciniani, ad esibirsi al teatro dell’Opera di Ruse divenendo ambasciatrice della grande tradizione musicale napoletana. Con lei sul podio dell’ Orchestra del teatro dell’Opera, per condurre il pubblico bulgaro in un viaggio che spazierà dalla tradizione classica a quella popolare in un arco temporale che attraverserà oltre tre secoli di musica, il Maestro Luca Gaeta, che firmerà anche gli arrangiamenti. Annalisa D’Agosto dividerà il palco con due tenori Mihail Mihailov e Petar Kostov con i quali attraverserà pagine che offriranno l’occasione all’uditorio di essere iniziato ad uno dei segreti della canzone napoletana, che non è soltanto nella vocalità morbida nella sua vena melanconica e ornata alla maniera orientale, ma creazione di “affetti” e atmosfere. La serata principierà con l’Inno del Regno delle Due Sicilie, scritto e musicato da Giovanni Paisiello e commissionato da re Ferdinando I nel 1787, ma adottato nel 1816. Il testo nel tempo subì varie modifiche; venne ritrovata una partitura che conteneva il testo dell’inno datata tra il 1835 e il 1840. Si passerà, quindi a due pagine di Giovanni Battista Pergolesi con la prima, quel “Se tu m’ami”, tratta dalle celeberrime Arie antiche, pubblicate da Ricordi tra il 1885 e il 1888. Questa antologia, curata dal compositore e critico Alessandro Parisotti, seguiva la moda per l’antico invocato da Verdi (il suo motto “Tornate all’antico e sarà un progresso”) di utilità agli insegnanti di canto (che infatti se ne valgono ancora oggi), Parisotti dava un’immagine falsata del repertorio Sei-Settecentesco come “facile” ed edulcorava le composizioni musicali tagliuzzandole e riarmonizzandole a piacimento.
Ma, a parte casi di attribuzioni erronee tradizionali quali la “canzonetta” di Salvator Rosa, tutte le arie da lui pubblicate erano autenticamente “antiche”. Sembra fare eccezione proprio “Se tu m’ami”. Il testo è tratto da quattro strofe estrapolate da una più lunga canzonetta del Rolli, il cui senso viene parzialmente travisato dalla sostituzione di “Silvio” con “Silvia”. La musica, pur ricalcando alcuni stilemi pergolesiani, sembra effettivamente un falso moderno, tanto più che non è mai stato trovato nessun manoscritto settecentesco che la riporti. A seguire l’aria di Serpina da “La serva padrona” “Stizzoso, mio stizzoso”, in cui l’invenzione sgorga gioconda e delicata, concedendo il frizzo del sussulto emotivo ed ironico. A seguire, “Fenesta vascia”, un altro successo trascritto da Guglielmo Cottrau, di una canzone per la quale si è parlato del Seicento e del Settecento, probabilmente perché le prime due strofe costituiscono il testo di un canto popolare riportato anche da Molinaro Del Chiaro nella sua raccolta, tuttavia, l’andamento del brano, così come è conosciuto e amato, sembra essere decisamente ottocentesco. La melodia di Saverio Mercadante e del suo librettista Marco d’Arienzo, sarà celebrata con “La rosa” datata 1848, dalla fresca e creativa invenzione. Si continuerà con Canzona Marinara, composta da Gaetano Donizetti nel 1835, conosciuta ai più con il suo incipit “Me voglio fa’ na casa”, dedicata al celebre basso Luigi Lablache. Ancora Donizetti, ma è solo un falso, con la fortunatissima canzone un tempo a lui attribuita, “Te voglio bene assaje”, ma composta nel 1839, dall’ottico Raffaele Sacco e da Filippo Campanella, prima di evocare la sfida lanciata a Gabriele D’Annunzio sui tavoli del Gambrinus da Ferdinando Russo per una lirica in vernacolo partenopeo, che dette vita alla canzone “’A vucchella” su musica di Francesco Paolo Tosti.
Infatti, D’Annunzio scrisse il testo, per scommessa, volendo dimostrare all’amico che contrariamente a quanto questi scherzosamente sosteneva, anche un poeta di origini non partenopee era in grado di scrivere una canzone napoletana. “L’ultimo suo lavoro è uno dei non pochi ricordi di quel delizioso Mezzogiorno, dove i canti popolari escono spontanei, melodici, e per imitarli ci vuole un’attitudine particolare, della quale il Tosti è provvisto abbondantemente. Il canto napoletano, da lui recentemente pubblicato, è uno dei suoi migliori per il carattere giusto, la snellezza e il fuoco che lo riscalda. S’intitola “Marechiare”, dal nome di un paesello, in riva al mare, ed i versi, molto graziosi, sono di Salvatore di Giacomo, buon poeta popolare”. Con queste parole, pubblicate sulla Gazzetta Musicale di Milano nel 1886, il giornalista Filippo Filippi sembra aver racchiuso completamente la poesia che si cela all’interno di una delle canzoni napoletane più celebri: A Marechiaro. Reale era la finestra con il garofano sul davanzale e reale era anche una giovane che si chiamava Carolina, moglie di uno dei proprietari di quell’osteria dove l’artista si era seduto la prima volta. Dell’ispirazione di Francesco Paolo Tosti, si sa invece, che trasse quella melodia così semplice eppure così ammaliante, ispirandosi alle note intonate da un posteggiatore. L’uomo ogni sera prima di iniziare, con il suo flauto, ad accompagnare le canzoni del suo compagno suonava, per esercitarsi, quello stesso motivetto che apre A Marechiaro. Ancora un’intensa pagina napoletana composta nel 1900 dal ciabattino poeta Vincenzo Russo e dal musicista “squattrinato” Eduardo Di Capua, “Torna maggio”, seguita dalla brillante Tarantella di Raffaele Calace, secondogenito del liutaio Antonio, il quale dedicò la sua vita musicale ai plettri, e ancora, “I te vurria vasà” che ha origine dall’amore infelice dell’autore Vincenzo Russo, un modesto calzolaio, per Enrichetta Marchese: i versi, composti sul finire del 1899 da Russo, furono musicati tra il 1º e il 2 gennaio 1900 da Eduardo di Capua, famoso autore di ‘O sole mio, nonché amico e sodale di Russo con Alfredo Mazzucchi. Gran finale con “Torna a Surriento”di Giambattista ed Ernesto De Curtis, melodia che nacque come canzone occasionale –oltretutto in una stesura diversa da quella che conobbe il successo-, come omaggio e “memento” per l’allora ministro Zanardelli, il quale aveva promesso di dotare la città di un modernissimo ufficio postale, con l’episodio raccontato dal M° De Curtis, secondo cui le note del ritornello gli erano state suggerite da un uccellino che cinguettava su di un albero di arance; ‘O sole mio, praticamente il secondo inno d’Italia creata dalla penna di Giovanni Capurro, giornalista e redattore delle pagine culturali del quotidiano Roma di Napoli, poi affidata ad Eduardo Di Capua, che si trovava a Odessa, nell’Impero russo, ispirata da una splendida alba sul mar Nero e, soprattutto, dalla nobildonna oleggese Anna Maria Vignati-Mazza detta “Nina”, sposa del senatore Giorgio Arcoleo e vincitrice a Napoli del primo concorso di bellezza della città partenopea.
Non mancheranno “Funiculì Funiculà”di Turco e Denza che descrive ai napoletani e soprattutto ai turisti i vantaggi offerti dal nuovo mezzo di trasporto, la funicolare, che permette di salire senza fatica, ammirando il panorama, melodia incorporata nel movimento finale del poema sinfonico Dall’Italia di Richard Strauss, ispirato dal viaggio nella nostra nazione, compiuto dal compositore e nella rapsodia Italia di Alfredo Casella e Santa Lucia luntana, senza dubbio la più bella canzone di E. A. Mario, che esprime la nostalgia dell’emigrante con accenti sinceri che sanno esprimere una sofferenza viva, ma anche una luce di speranza. Un viaggio simbolo di un filone inesauribile di fantasia e ricchezza poetica da cui nasce e di cui si nutre la creatività di un intero popolo che sa ricordare, raccontare, ascoltare e tramandare, i mille volti e dalle mille contraddizioni, diviso fra l’estrema vitalità e lo smarrimento più profondo, una città di cui la lingua è il più antico segno, forgiato dal tempo e dalle contaminazioni, una identità sedimentata da sedimentata da quattro secoli di letteratura.