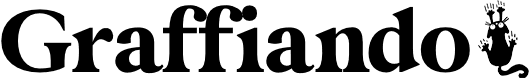Al teatro Verdi è andato in scena quel giocattolo sonoro che è uno dei capolavori del genio di Pesaro. Felice l’idea registica di Sarah Schinasi, che ha voluto Isabella aviatrice. Su tutto e tutti le voci di Carlo Lepore e Marco Filippo Romano, Mustafà e Taddeo, insieme agli “strumentini”. La direzione di Gaetano Lo Coco ha portato l’ammiraglia in porto alla ricerca continui di equilibri. Si replica questa sera, alle 18.
di OLGA CHIEFFI
Ricorderete le parole di donna Prassede “Si sa che agli uomini il bene bisogna, le più volte, farlo per forza” ed è un segno confortante che in questo week-end, il Teatro Verdi di Salerno e il Lirico di Cagliari, abbiano puntato sul titolo rossiniano “L’Italiana in Algeri”. Non che si voglia instaurare una stolta antitesi Rossini-Verdi o Rossini-Puccini, ma abbiamo toccato con mano che certo pubblico è ormai avvezzo unicamente alla travolgente forza drammatica di Giuseppe Verdi o a certo melodismo emozionale di Giacomo Puccini autori, questi, capaci di soggiogare l’ascoltatore, perfino là dove il linguaggio musicale è ancora lontano dall’assoluto musicale. Chi ama Rossini ama, in lui, la musica e nient’altro, non ci sono altri argomenti, altri interessi, altre lusinghe che possano avvicinare a lui. Rossini è della famiglia di Bach e di Mozart, magari di Brahms. Verdi, come Beethoven, lo può gustare ed amare anche qualcuno che con la musica non abbia piena e totale confidenza. Questa riconquista di Rossini al gusto contemporaneo, non è passata senza qualche velata resistenza da parte di un pubblico pur assiduo frequentatore del massimo cittadino e riconosciamo a Daniel Oren il merito di aver marciato senza remore, un poco contro corrente, per contribuire al graduale affinamento del gusto musicale dell’uditorio salernitano. Per far questo si è fidato dei suoi legni, principi assoluti di un’orchestra sibaritica, alla prima, nel suo suono, che ridotta, come da partitura, ha trasformato tutti in solisti. Menzione, quindi, per Giovanni Mainenti degno primo corno, per Antonio Rufo, giustamente e finalmente primo oboe, suono in simbiosi col primo flauto Antonio Senatore, con al suo fianco l’ottavino spaziale di Vincenzo Scannapieco, duci di una linea in grande spolvero, in un’opera che li vuole “parlanti”, affermazione di una scuola che ha alternato a quei leggii e nella didattica, maestri e allievi sin dall’inizio del secolo breve, una sezione quella dei legni, in cui includiamo anche clarinetti e fagotti, che, dopo questa brillantissima prova, ci auguriamo possa restare tale per le prossime produzioni. Il giovane maestro Gaetano Lo Coco ha chiuso in scatola il giocattolo sonoro, cercando un continuo equilibrio, quella tendenza all’oggettività, in reazione agli sbilanciamenti e agli eccessi ottocenteschi, prendendosi il rischio di guardare ad un fantomatico Mozart, trascurando, così, quello “stacco radicale che separa Rossini dallo spirito del Settecento”, per dirla con Fedele d’Amico e mettendo un tappo al fine perlage dell’orchestra, alla quale avrebbe potuto chiedere tanto di più. Ma, la grandezza di Rossini è tale che ci si ritrova sempre anche con interpretazioni diverse, attraverso cui si riescono a rivelare anche bellezze nascoste, come, in questo caso, nel momento in cui Isabella e Lindoro si riconoscono alla corte di Mustafà. Cast dominato da Carlo Lepore, il quale, come sempre, ha dato lezione di canto e di teatro, re del sillabato, dal virtuosismo vocale eletto, toni bruniti, accattivanti, il quale ha sposato l’idea registica di un Mustafà vero, reale e rossiniano, unitamente a Marco Filippo Romano, un Taddeo d’eccezione, di voce bella, timbrata e piena, un personaggio tutto da godere ed ascoltare parola per parola. Una decisa spanna al di sotto di questi due campioni di belcanto, il resto del cast, platealmente dismogeneo negli assiemi, a cominciare dal tenore Juan De Dios Mateos, petulante, nelle sue arie, non certo cesellatore di belcanto, forse sottoposto alle inique esigenze di un diapason crudele, che non è più quello dei tempi di Rossini, ma perfetto nei panni dell’archeologo, una Isabella di carattere, la Elmina Hasan, in scena, dignitosa nel fraseggio, anche se con qualche fiato dubbio e poco volume, addirittura sopraffatta dall’orchestra e dai due protagonisti, in diversi numeri. Buon debutto di Nicola Ciancio nel ruolo di Haly, con la sua aria chiave “Le femmine d’Italia”, di una comicità signorile unitamente alla Zulma di Rosa Bove, mentre una vocina leggerissima, penetrante e piagnucolosa è la Elvira della bellissima Mariam Battistelli.
Il coro ben preparato da Francesco Aliberti, è riuscito nel compito non semplice di diventare personaggio, schizzando tre caratteri, attivo della storia, a cominciare dall’esordio, passando per “Viva il grande Kaimakan”. Plauso al maestro al cembalo, Maurizio Iaccarino che non ha fatto mancare il suo inconfondibile “Witz”, con la sfida lanciata al pubblico, a riconoscere le varie simpatiche citazioni, tra cui la Marsigliese. Applausi per tutti e per l’idea registica di Sarah Schinasi, che ci ha trasportato in un’atmosfera liberty, prolungando, così, anche i festeggiamenti per il centenario della nostra Aeronautica, trasformando Isabella in una pioniera del volo. L’impianto scenico realizzato da Alfredo Troisi, rapidamente variato, non ha guardato leziosamente ad un Oriente immaginario da cartone animato, ma al realismo dei costumi borghesi attribuiti al serraglio di Mustafà, come nella emblematica scena del caffè. Finale con il banchetto da Pappataci, che consuma il suo pasto, nel momento in cui gli italiani stanno prendendo il largo alle sue spalle sul veloce brigantino, non lontano però, come l’idea borghese, dalla mise en scene scaligera di Jean Pierre Ponnelle datata 1973. Lancio di rose, per tutti, anche per lo stesso Rossini, intervenuto in palcoscenico per dirimere il finale del I atto. Si replica questa sera alle ore 18.