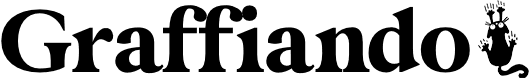Giovedì sera, alle ore 21, il sipario del teatro Verdi di Salerno, si leverà sul “Berretto a Sonagli”. Abbiamo raggiunto il maestro a qualche giorno dal debutto del capolavoro pirandelliano, il quale ci ha svelato le sue ragioni estetiche della rappresentazione
di MARIANGELA STANZIONE
Il berretto a sonagli è una vicenda del tutto terrena e umana, ma non per questo perde di emozione e di profondità: le figure di Beatrice e di Ciampa, uniti nell’essere vittime e divisi nel modo di affrontare il peso dell’essere traditi, dominano e assorbono su di loro tutta l’attenzione, rendendo gli altri personaggi semplici comparse mentre in palcoscenico si urla, si piange, si corre, si soffre: siamo tutti Pupi nel grande teatro del mondo, talmente affezionati al nostro ruolo che non solo lo accettiamo, ma vogliamo in fondo mantenerlo a tutti i costi.
Abbiamo raggiunto il maestro, qualche giorno prima del suo debutto qui a Salerno, sul palcoscenico del Teatro Verdi, che lo ospiterà insieme alla sua compagnia dal 2 al 5 marzo.
Qual è il suo primo ricordo del teatro?
“È antichissimo… Da bambino mio padre mi portò a vedere Cyrano de Bergerac di Gino Cervi. Mi sono annoiato a morte! Mia madre disse “Non ti ci porto più!”, una vera tragedia… Alla fine mio padre condusse me e i miei fratelli ai camerini; bussò; lui apparve in una veste rossa; mi diede una carezza sulla testa; e mio padre disse “bambini, il signore è il grande Gino Cervi”. Queste parole non le dimenticherò mai. Ma dello spettacolo non capivo nulla. Erano molto più belle le figure sui libri illustrati; le figure sul palcoscenico, mio Dio, come erano brutte! Non che fossero brutte… ma era molto più bello immaginarsele.
Ma nel momento in cui mia madre disse “Non ti ci porto più” era passato lo spiritello dispettoso. “Adesso te la combino io grossa!”. Ed eccomi qua.
Come vive il processo di creazione dello spettacolo? E in che misura i suoi attori vi prendono parte?
“Per quel che riguarda me, il regista è il primo a leggere il testo. Ci metto più tempo a studiare un testo che a metterlo in scena. Disegno tutto quello che riguarda lo spettacolo, anche con scarabocchi… Quando arrivo a tavolino, io so già tutto, altrimenti non c’è tempo. Le ultime prove, dello spettacolo in sé e per sé, sono le più importanti, ma devo sapere tutto prima. Non sono un improvvisatore.
Tutto ciò come si scontra con la materialità, la contingenza?
“Gli attori sanno che c’è un signore che ha studiato a lungo e di cui si fidano. Io arrivo con una chiarezza di “idee non chiare”. Ho chiaro che ho le idee opache, che bisogna chiarirle man mano con la voce, col corpo, con l’essere degli attori che ho di fronte. Purtroppo, poi bisogna andare in scena, ma se un teatrante potesse provare sempre, senza mai andare in scena, sarebbe la cosa più bella che possa capitare”.
Lei ha detto che l’attore non è una presenza ma una assenza in scena. In che modo si assenta da sé per lasciar posto al personaggio?
“L’attore grande ha una presenza che si assenta. Il personaggio dovrebbe vivere per sé. E questo per sé vorrebbe dire che l’attore che lo incarna riuscisse a togliere di sé il massimo di sé (sic). È un concetto filosofico che ha a che fare con l’essere o non essere. Cos’è più importante? Io credo che su, in scena, bisogna ricercare il non essere. Ma non ci si riesce mai. Bisognerebbe, per un attore, ogni volta che fa un personaggio nuovo, che il pubblico nemmeno lo riconosca. E questo vorrebbe dire essere grandissimi”.
Ha anche detto che il teatro è essenzialmente flusso e che, come la vita, non si fissa mai. Come concilia tale esigenza del teatro con la scelta di un approccio registico tradizionale?
“La regia, che è indispensabile, è la mala essenza del teatro. L’ideale è che non ci fosse la regia; se c’è, l’ideale è che non si veda. È come l’amore: è bello se, ogni volta che lo fai, è come fosse la prima volta. Altrimenti diventa una ripetizione, una prostituzione. L’attore non si può prostituire alla sua parte, ma deve amarla come fosse la prima volta. Ogni sera lo è. Ed è sempre diverso, ma sempre lo stesso. C’è una stessità nella diversità. È un po’ difficile, ma semplice.
In questo momento storico il teatro non è una forma d’arte popolare; è percepito come ostico o vetusto, sicuramente arroccato. In che modo proverebbe a rinfocolare la passione, specie nelle nuove generazioni?
“Io non devo suscitare passione. Non credo, intanto, all’ “io il teatro non lo capisco” di gente che non c’è mai stata, che ripete un modo di dire. Ovviamente tutto la prima volta non è semplice. È semplice andare a cavallo? No. Però, una volta che ti applichi, non puoi più farne a meno, una volta andavo a cavallo, la cosa che più ho amato nella vita. Ma andare a cavallo vuol dire studiare. “Vado a teatro” non è come “vado al cinema”, dove ci sono solo io, e le figure che si muovono sono proiezioni, fantasmi. A teatro non è la stessa cosa: ci sono io e ci sono gli altri dall’altra parte. Bisogna sapere di cosa si parla, perché c’è uno scambio di intelligenze. Ha un nome antico: thea-tron, “Il trono della dea”, quella che i greci chiamarono “Svelatezza”, tradotta male dal giudaismo cristiano con Veritas. I greci non hanno la “verità”; hanno solo la “svelatezza” dell’incomprensibile che è l’uomo. È per questo che i greci hanno inventato il pensiero umano”.
Lei frequenta Pirandello da molti anni. Cosa ha trovato, in questo tempo, che di lui non sia mai stato detto o sottolineato abbastanza? E come, col suo teatro, cerca di portarlo in luce?
“Io non scopro nulla quando metto in scena un testo: spero che il testo scopra qualcosa di me. È un approccio completamente diverso. Siamo rovinati dal concetto che dobbiamo avere una nostra visione: un errore di arroganza occidentale. Io non faccio Pirandello, è Pirandello che fa me. Non metto in scena il Berretto a sonagli, ma quello che il Berretto a sonagli ha trasformato in me. Io non posso mettere in scena un altro; posso mettere in scena solo Io. Non che il Berretto a sonagli diventi mio, ma la mia rappresentazione. E questo lo dice lo stesso Pirandello”.