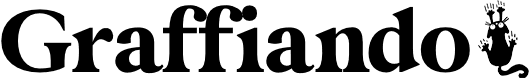Una delle “rotture” della musica ha inaugurato il 2025, dell’Orchestra Filarmonica del Teatro Verdi, affidata alla bacchetta di Francesco Ivan Ciampa con solisti Juliana Grigoryan, Dmitry Korchak, Elmina Hasan e Mikhail Petrenko. Poche prove, niente raddoppi, per una partitura, indomabile da un gesto astenico, nascosto dietro il termine spirituale. Diverse le incomprensioni tra le sezioni dell’orchestra finanche nell’attacco del soprano. Il corale ha messo tutti d’accordo, fino al bis del finale
La IX sinfonia in re minore per soli, coro e orchestra, op.125 “Corale” di Ludwig Van Beethoven ha inaugurato, seriamente, dopo l’abituale concerto di Capodanno, il nuovo anno musicale del Teatro Verdi di Salerno e della sua orchestra. Uno sforzo disumano, per prove ed esecuzione, questa richiesta agli strumentisti, venuta tra una Traviata, i tre appuntamenti del primo giorno dell’anno, la VII sinfonia del genio tedesco a seguire, che è andata a sostituire l’annunciata Sinfonia n. 9 in Mi minore op. 95 “Dal Nuovo Mondo” di Antonin Dvoràk e il concerto per violino in Re Maggiore op.35 di Petr Ilic Cajkovskij, che ha salutato quale solista Pavel Berman. Francesco Ivan Ciampa sul podio. Le aspettative per l’esecuzione di questo monumento, concerto clou del cartellone di gennaio di Musica d’artista, firmato da Daniel Oren e Antonio Marzullo, erano elevate per questo evento, considerando la grande importanza e la complessità dell’opera. Purtroppo, Il direttore che, a sua detta, ha inteso scegliere una via spirituale per la lettura di questa opera, ha evidenziato un gesto astenico, che ha causato diverse incomprensioni tra le sezioni, a cominciare dagli ottoni, i corni che hanno sporcato diverse entrate, diversità d’intenzione, di fraseggio, tra gli archi, un approccio un po’ superficiale, ad un’opera particolare e atipica. Non è la parte iniziale con la sua caratteristica quinta vuota l’inizio per antonomasia, che ha messo in difficoltà la formazione, e il movimento conclusivo il Finale per eccellenza? Il fatto che abbia concepito Beethoven il Finale della Nona in forma di variazione, si chiarisce in tutta evidenza con l’idea di una fusione estatica e globale, nata da una figura centrale e realizzata con mezzi musicali autonomi. E questo carattere è insito nello stesso tema della “Gioia”. Come sintesi ideale – ma questa volta nel senso d’una ricerca abissale – si configura l’Adagio molto e cantabile, anch’esso in forma di variazione. Ma intanto il mondo della Nona Sinfonia è ben più ampio: se nei primi due movimenti si liberano forze esistenziali poderosamente tese, in quello lento l’io diviene consapevole della forza del ripiegamento interiore e delle istanze emotive, mentre il Finale instaura per l’ultima volta nella storia della musica quell’armonia tra ordine umano e cosmico-divino, quale è resa possibile dalla volontà morale della personalità creativa di Beethoven, in un’epoca in cui lo straniamento già cominciava a profilarsi all’orizzonte. Di questo giusto tentativo di lettura ci è giunto un apparente caos e la povertà timbrica nella prima parte, l’energia insufficiente della seconda, la fiacchezza e i colori sbiaditi dell’Adagio, che ha disassato la partitura del genio tedesco, nuances e di equilibri delicati tra le diverse sezioni. È andata un po’ meglio la celeberrima quarta parte, dove il coro preparato da Francesco Aliberti, pur tra tante spigolosità e sufficiente amalgama è riuscito a rendere più vitale l’esecuzione della sinfonia. Disorientate anche le quattro belle voci, poco valorizzate, impegnate nel capolavoro beethoveniano, pur messe a dura prova dalla scrittura, Juliana Grigoryan, Dmitry Korchak, Elmina Hasan e Mikhail Petrenko, con il soprano che si è trovato seriamente in difficoltà nel suo intervento solistico. Un risultato finale nel complesso, caratterizzato da sonorità piatte e dalla mancanza dei tipici “tuoni” beethoveniani. La nostra tradizione resta quella dei legni, con menzione, per i flauti guidati da Antonio Senatore, con a fianco Mario Montani e l’ottavino sopra le righe di Vincenzo Scannapieco, virtuosi non solo dal punto di vista tecnico, ma soprattutto interpretativo, capaci di raffinatezze d’espressione, su di una tessitura acuta per l’intera partitura, risolta con una sicurezza stupefacente, in accordo con clarinetto ed oboe, alla eterna ricerca di un timbro caldo e rotondo anche nei passaggi di maggior esposizione. Non è stato il Beethoven idealistico e marmoreo che qualche purista in sala si attendeva, né quello nervoso e coinvolgente, lirico e magnetico, al quale ci ha ben abituato il Maestro Daniel Oren. Per Husserl, “il maggior pericolo dell’Europa è la stanchezza”, ci stiamo cadendo in pieno, e l’esecuzione di questa sinfonia in questi tempi ha da riaccendere proprio la grande e disperata vitalità che dovrebbe governare la Storia, fuori di qualunque “stanchezza”, ovvero la resurrezione dello spirito, da ottenere calandosi nelle viscere del suono, per offrirne lo specchio percepibile, in modo da far risvegliare questa nostra società piagata dalla barbarie morale, che sta conducendoci a un disfacimento totale, e riuscire, così, a far rinascere quell’eroismo della ragione che è proprio dello spirito umano “O Freunde, nicht diese Töne! Sondern laßt uns angenehmere anstimmen und freudenvollere”. Applausi e bis del finale.