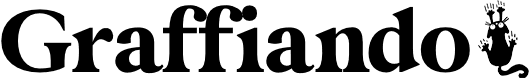Sui due cast, andati in scena al Teatro Verdi di Salerno per il capolavoro verdiano, che ha chiuso il cartellone lirico, il carisma assoluto di Daniel Oren, alla testa di un’Orchestra Filarmonica che ha rivelato le sue potenzialità e la voce di Gilda Fiume, toccata e fuga per la seconda replica. In una Parigi Belle Époque la solitudine di Violetta, essenza di un’opera che muore d’amore
Non è lontana dalla Maria Callas, evocata nel film di Pablo Larrain, La Traviata andata in scena al Teatro Verdi di Salerno, quale sigillo alla stagione lirica 2024. Violetta, ha avuto la doppia voce di Irina Lungu, per la prima e l’ultima replica, e di Gilda Fiume per la seconda rappresentazione, due interpretazioni diverse, per la bacchetta di Daniel Oren, ispirata come non mai, e la regia di Giandomenico Vaccari, il quale ha scelto di trasporre l’opera nella Parigi dei primi decenni del secolo breve, il cui gusto estetico nel fervore di una moda che, dalle raffinatezze della Belle Époque andrà, poi, lentamente esaurendo, “sottilmente”, nel corso del ventennio. Vaccari, in ogni atto ha sentito di porre diversi segni intertestuali per rafforzare l’interpretazione prismatica del tempo e delle emozioni nel corso dell’opera, vestendo gli interpetri con tessuti di satin con ricami in rilievo aigrettes nei capelli, perle e fruscianti frac. Il regista, per le scene affidate ad Alfredo Troisi si è affidato al simbolo dello specchio, che campeggia nel I atto al centro riflettendo la società del tempo e la nostra, metateatro simbolo dell’universalità della musica e del dramma, non lontano da quel Don Giovanni scaligero del 2011 firmato da Robert Carsen, nella sua polivalenza, come visione del mondo e della vita. Un mondo dove l’apparire conta più dell’essere, dove l’amore si riduce a consumo erotico e non a rapporto amoroso, relegante alla solitudine, una Violetta star dei salotti, intrappolata di un mondo di aspettative e pressioni insostenibili, una gabbia, per una donna vulnerabile, piena di insicurezze e desideri inappagati, che la porta alla depressione e alla allucinazione da farmaci, nei momenti di introspezione, in cui si interroga sulla propria identità e sul significato di essere amata e riconosciuta. Gli specchi deformanti, che delimitano i tre spazi in cui si svolge l’opera, incarnano le ansie di Violetta, le sue visioni distorte, riflessi della sua mente che si dibatte in una condizione esistenziale universale: la ricerca di un posto nel mondo e il prezzo da pagare. Un viaggio tra realtà e illusione, in una storia di vulnerabilità e lotta, un tema che risuona fortemente nel nostro tempo, dove l’apparenza spesso nasconde una verità ben più complessa, in cui Violetta diviene l’eterna cercatrice di un senso, di una connessione autentica in un mondo che sembra privilegiarne l’immagine piuttosto che la sostanza. Nel finale il libretto obbliga il regista a far finire Violetta per tisi, per la quale non c’è descrizione reale più perfetta, emotorace, shock e morte. Giandomenico Vaccari fa tornare i fantasmi in un flashback in cui Violetta vede se stessa da bambina, quindi, nelle varie età, sino a far intuire la Callas, con il foulard in testa e gli occhiali. Sul Carnevale parigino piove, tanti i simboli in questa scelta, riferimento ai liquidi che avvolgono il feto nel grembo materno, morte, resurrezione, rigenerazione, la morte-bambina porta via Violetta, che rinascerà nell’Oltre, libera del corpo, come avverrà con la musica, ogni volta che sarà riaperta la partitura de’ La Traviata, fino alla fine dei tempi. Due Violette per questa produzione, entrambe apprezzabili, diverse. La performance di Irina Lungu nel primo atto è stata caratterizzata da una certa tensione, comprensibile in vista dell’impegno della cabaletta, “Sempre libera degg’io”. “Ah fors’è lui che l’anima” è stato il momento migliore del I atto. La sua voce, dal timbro scuro e dalla risonanza calda, ha presentato alcuni acuti che sono risultati freddi, con il mi bemolle finale teso dopo una serie di agilità in una cadenza ridotta all’essenziale. Momento culminante della serata è stato “Addio, del passato bei sogni ridenti”, in cui la Lungu è riuscita ad esprimere una grande intensità emotiva sul filo del suono dell’oboe di Antonio Rufo, che è sembrato anch’egli abbandonarsi al soffio di un’utopia ormai svanita, grazie alla tessitura di questa aria che si adatta perfettamente alla voce della Lungu e alla lettura di Daniel Oren che ha contribuito ad esaltarne la bellezza. Trionfo annunciato per Gilda Fiume, una toccata e fuga la sua, direttamente da Verona dalle prove del Falstaff di Antonio Salieri, in scena dopo un tour de force di una giornata e mezza, praticamente senza prove. Daniel Oren ha scelto lei per far musica per una sola performance “Che un giorno sol durò” (citazione belliniana, questa, che potrebbe essere un suggerimento e un invito per la prossima stagione) e loro due, insieme all’orchestra l’hanno avuta vinta su tutto e tutti. Prestigio del gioco d’emissione, nel chiarire o scurire le vocali, tornire la sillabazione, un di più che risiede, appunto, in un atto di intelligenza, di sensibilità, anche critica, albana d’oro scintillante nella cabaletta “Sempre libera degg’io”, in cui ha cantato gli acuti, mostrando ottime qualità tecniche, da pupilla della Mariella Devia e un timbro piacevole, con quella carica emotiva necessaria per rappresentare appieno il tormento del suo personaggio. Violetta ha da affrontare un secondo atto in duetto con Giorgio Germont. Il baritono Simone Piazzola è sembrato mancare di quella forza espressiva necessaria per interpretare un personaggio complesso come il padre di Alfredo. Sebbene abbia un timbro gradevole, la sua mancanza di nerbo si è fatta sentire, specialmente nei momenti in cui sarebbe richiesta una maggiore intensità emotiva. La sua esecuzione nei passaggi cantabili è risultata a sprazzi più convincente, ma qualche difficoltà di intonazione nel registro acuto, i tentativi di utilizzare legato e mezza voce non felice, hanno limitato la sua performance, privando il personaggio di quella vitalità e dinamicità che sarebbero invece fondamentali in un contesto così drammatico. Un po’ di delusione è venuta da Valentin Dytiuk che ricordiamo giovanissimo quale Rodolfo, un perfetto Nemorino e nelle vesti del Duca di Mantova, ma Alfredo non è ancora suo, si è trovato in grave difficoltà sul registro acuto, nella cabaletta del II atto, “Oh mio rimorso! Oh infamia!”, su quel do, che è stata croce e delizia sin dalla prima, dizione non chiarissima e la recitazione, poi, ha fatto rimanere Alfredo un bamboccione fino alla fine. Alessandra Croce ha dato voce ad una Flora Bervoix dignitosa, come lo è stato il Gastone di Vincenzo Peroni, il barone Duphol di Angelo Nardinocchi e, ancora, un brillante Marchese d’Obigny quello di Costantino Finucci, con, a completare il cast, il dottor Grenvil, Carlo Striuli, l’Annina di Miriam Artiaco, il Giuseppe di Paolo Gloriante e il domestico di Antonio De Rosa. Magistrale e trascinante la direzione di Daniel Oren, alla testa di un’orchestra dominata in assoluto dai legni, due i soli attesi quello del clarinetto di Luigi Pettrone, il ricordo, il coraggio per scrivere e lasciare l’amore (e la vita), un climax emozionalmente creato dalla sua ancia, che poi esploderà nell’Amami Alfredo e quello dell’oboe, introduzione alla consapevolezza della morte e alla speranza di essere eternata nella memoria di qualcuno. Tra la prima e la seconda recita, certo, incomprensioni ce ne sono state diverse, tra buca e palcoscenico, come nella premiere, tra il coro e barone Duphol, banda di palcoscenico fuori tono, volume e tempo, ma Oren ha ritagliato per sé e l’orchestra i preludi, in cui gli strumenti diventano le chiavi della psicologia dei personaggi, entrambi cadenzati dalla cellula della morte, alla ricerca dei silenzi, ove s’asconde la musica. Il Maestro ha sollevato l’orchestra in ondate omogenee e piene di sonorità, possenti, per una lettura scevra da ogni incrostazione, oramai di tradizione. All’inizio del II atto, con la cabaletta di Alfredo abbiamo ascoltato l’intensità di violoncelli e flauti, quale espressione della vergogna e del nervosismo del personaggio, le isterie delle due feste, riflesso di una condizione privatissima, hanno trovato spietato risvolto nelle melanconiche intermittences du coeur degli aliti di Violetta morente, appena spezzati dall’irruzione delle taglienti ventate dell’ottavino, insuperato di Vincenzo Scannapieco, che percorrono, fuori scena, il coro del “bue grasso” di Carnevale. Buona prova del coro, in particolare delle voci femminili, preparato da Francesco Aliberti, che ha valorizzato il quadro centrale del II atto, con anche i danzatori, per le coreografie di Luigi Ferrone, con le étoile ospiti, Alessandro Macario e Giorgia Giammona, che hanno avuto il ruolo di accompagnare ed essere specchio delle visioni, di Violetta. Applausi, diverse chiamate al proscenio, lancio di rose e, qualcuno, sullo svanire della vita, ha versato calde lacrime, poiché la Traviata è un’opera che muore d’amore. (le immagini sono di Pasquale Auricchio)






 Non è lontana dalla Maria Callas, evocata nel film di Pablo Larrain, La Traviata andata in scena al Teatro Verdi di Salerno, quale sigillo alla stagione lirica 2024. Violetta, ha avuto la doppia voce di Irina Lungu, per la prima e l’ultima replica, e di Gilda Fiume per la seconda rappresentazione, due interpretazioni diverse, per la bacchetta di Daniel Oren, ispirata come non mai, e la regia di Giandomenico Vaccari, il quale ha scelto di trasporre l’opera nella Parigi dei primi decenni del secolo breve, il cui gusto estetico nel fervore di una moda che, dalle raffinatezze della Belle Époque andrà, poi, lentamente esaurendo, “sottilmente”, nel corso del ventennio. Vaccari, in ogni atto ha sentito di porre diversi segni intertestuali per rafforzare l’interpretazione prismatica del tempo e delle emozioni nel corso dell’opera, vestendo gli interpetri con tessuti di satin con ricami in rilievo aigrettes nei capelli, perle e fruscianti frac. Il regista, per le scene affidate ad Alfredo Troisi si è affidato al simbolo dello specchio, che campeggia nel I atto al centro riflettendo la società del tempo e la nostra, metateatro simbolo dell’universalità della musica e del dramma, non lontano da quel Don Giovanni scaligero del 2011 firmato da Robert Carsen, nella sua polivalenza, come visione del mondo e della vita. Un mondo dove l’apparire conta più dell’essere, dove l’amore si riduce a consumo erotico e non a rapporto amoroso, relegante alla solitudine, una Violetta star dei salotti, intrappolata di un mondo di aspettative e pressioni insostenibili, una gabbia, per una donna vulnerabile, piena di insicurezze e desideri inappagati, che la porta alla depressione e alla allucinazione da farmaci, nei momenti di introspezione, in cui si interroga sulla propria identità e sul significato di essere amata e riconosciuta. Gli specchi deformanti, che delimitano i tre spazi in cui si svolge l’opera, incarnano le ansie di Violetta, le sue visioni distorte, riflessi della sua mente che si dibatte in una condizione esistenziale universale: la ricerca di un posto nel mondo e il prezzo da pagare. Un viaggio tra realtà e illusione, in una storia di vulnerabilità e lotta, un tema che risuona fortemente nel nostro tempo, dove l’apparenza spesso nasconde una verità ben più complessa, in cui Violetta diviene l’eterna cercatrice di un senso, di una connessione autentica in un mondo che sembra privilegiarne l’immagine piuttosto che la sostanza. Nel finale il libretto obbliga il regista a far finire Violetta per tisi, per la quale non c’è descrizione reale più perfetta, emotorace, shock e morte. Giandomenico Vaccari fa tornare i fantasmi in un flashback in cui Violetta vede se stessa da bambina, quindi, nelle varie età, sino a far intuire la Callas, con il foulard in testa e gli occhiali. Sul Carnevale parigino piove, tanti i simboli in questa scelta, riferimento ai liquidi che avvolgono il feto nel grembo materno, morte, resurrezione, rigenerazione, la morte-bambina porta via Violetta, che rinascerà nell’Oltre, libera del corpo, come avverrà con la musica, ogni volta che sarà riaperta la partitura de’ La Traviata, fino alla fine dei tempi. Due Violette per questa produzione, entrambe apprezzabili, diverse. La performance di Irina Lungu nel primo atto è stata caratterizzata da una certa tensione, comprensibile in vista dell’impegno della cabaletta, “Sempre libera degg’io”. “Ah fors’è lui che l’anima” è stato il momento migliore del I atto. La sua voce, dal timbro scuro e dalla risonanza calda, ha presentato alcuni acuti che sono risultati freddi, con il mi bemolle finale teso dopo una serie di agilità in una cadenza ridotta all’essenziale. Momento culminante della serata è stato “Addio, del passato bei sogni ridenti”, in cui la Lungu è riuscita ad esprimere una grande intensità emotiva sul filo del suono dell’oboe di Antonio Rufo, che è sembrato anch’egli abbandonarsi al soffio di un’utopia ormai svanita, grazie alla tessitura di questa aria che si adatta perfettamente alla voce della Lungu e alla lettura di Daniel Oren che ha contribuito ad esaltarne la bellezza. Trionfo annunciato per Gilda Fiume, una toccata e fuga la sua, direttamente da Verona dalle prove del Falstaff di Antonio Salieri, in scena dopo un tour de force di una giornata e mezza, praticamente senza prove. Daniel Oren ha scelto lei per far musica per una sola performance “Che un giorno sol durò” (citazione belliniana, questa, che potrebbe essere un suggerimento e un invito per la prossima stagione) e loro due, insieme all’orchestra l’hanno avuta vinta su tutto e tutti. Prestigio del gioco d’emissione, nel chiarire o scurire le vocali, tornire la sillabazione, un di più che risiede, appunto, in un atto di intelligenza, di sensibilità, anche critica, albana d’oro scintillante nella cabaletta “Sempre libera degg’io”, in cui ha cantato gli acuti, mostrando ottime qualità tecniche, da pupilla della Mariella Devia e un timbro piacevole, con quella carica emotiva necessaria per rappresentare appieno il tormento del suo personaggio. Violetta ha da affrontare un secondo atto in duetto con Giorgio Germont. Il baritono Simone Piazzola è sembrato mancare di quella forza espressiva necessaria per interpretare un personaggio complesso come il padre di Alfredo. Sebbene abbia un timbro gradevole, la sua mancanza di nerbo si è fatta sentire, specialmente nei momenti in cui sarebbe richiesta una maggiore intensità emotiva. La sua esecuzione nei passaggi cantabili è risultata a sprazzi più convincente, ma qualche difficoltà di intonazione nel registro acuto, i tentativi di utilizzare legato e mezza voce non felice, hanno limitato la sua performance, privando il personaggio di quella vitalità e dinamicità che sarebbero invece fondamentali in un contesto così drammatico. Un po’ di delusione è venuta da Valentin Dytiuk che ricordiamo giovanissimo quale Rodolfo, un perfetto Nemorino e nelle vesti del Duca di Mantova, ma Alfredo non è ancora suo, si è trovato in grave difficoltà sul registro acuto, nella cabaletta del II atto, “Oh mio rimorso! Oh infamia!”, su quel do, che è stata croce e delizia sin dalla prima, dizione non chiarissima e la recitazione, poi, ha fatto rimanere Alfredo un bamboccione fino alla fine. Alessandra Croce ha dato voce ad una Flora Bervoix dignitosa, come lo è stato il Gastone di Vincenzo Peroni, il barone Duphol di Angelo Nardinocchi e, ancora, un brillante Marchese d’Obigny quello di Costantino Finucci, con, a completare il cast, il dottor Grenvil, Carlo Striuli, l’Annina di Miriam Artiaco, il Giuseppe di Paolo Gloriante e il domestico di Antonio De Rosa. Magistrale e trascinante la direzione di Daniel Oren, alla testa di un’orchestra dominata in assoluto dai legni, due i soli attesi quello del clarinetto di Luigi Pettrone, il ricordo, il coraggio per scrivere e lasciare l’amore (e la vita), un climax emozionalmente creato dalla sua ancia, che poi esploderà nell’Amami Alfredo e quello dell’oboe, introduzione alla consapevolezza della morte e alla speranza di essere eternata nella memoria di qualcuno. Tra la prima e la seconda recita, certo, incomprensioni ce ne sono state diverse, tra buca e palcoscenico, come nella premiere, tra il coro e barone Duphol, banda di palcoscenico fuori tono, volume e tempo, ma Oren ha ritagliato per sé e l’orchestra i preludi, in cui gli strumenti diventano le chiavi della psicologia dei personaggi, entrambi cadenzati dalla cellula della morte, alla ricerca dei silenzi, ove s’asconde la musica. Il Maestro ha sollevato l’orchestra in ondate omogenee e piene di sonorità, possenti, per una lettura scevra da ogni incrostazione, oramai di tradizione. All’inizio del II atto, con la cabaletta di Alfredo abbiamo ascoltato l’intensità di violoncelli e flauti, quale espressione della vergogna e del nervosismo del personaggio, le isterie delle due feste, riflesso di una condizione privatissima, hanno trovato spietato risvolto nelle melanconiche intermittences du coeur degli aliti di Violetta morente, appena spezzati dall’irruzione delle taglienti ventate dell’ottavino, insuperato di Vincenzo Scannapieco, che percorrono, fuori scena, il coro del “bue grasso” di Carnevale. Buona prova del coro, in particolare delle voci femminili, preparato da Francesco Aliberti, che ha valorizzato il quadro centrale del II atto, con anche i danzatori, per le coreografie di Luigi Ferrone, con le étoile ospiti, Alessandro Macario e Giorgia Giammona, che hanno avuto il ruolo di accompagnare ed essere specchio delle visioni, di Violetta. Applausi, diverse chiamate al proscenio, lancio di rose e, qualcuno, sullo svanire della vita, ha versato calde lacrime, poiché la Traviata è un’opera che muore d’amore.
Non è lontana dalla Maria Callas, evocata nel film di Pablo Larrain, La Traviata andata in scena al Teatro Verdi di Salerno, quale sigillo alla stagione lirica 2024. Violetta, ha avuto la doppia voce di Irina Lungu, per la prima e l’ultima replica, e di Gilda Fiume per la seconda rappresentazione, due interpretazioni diverse, per la bacchetta di Daniel Oren, ispirata come non mai, e la regia di Giandomenico Vaccari, il quale ha scelto di trasporre l’opera nella Parigi dei primi decenni del secolo breve, il cui gusto estetico nel fervore di una moda che, dalle raffinatezze della Belle Époque andrà, poi, lentamente esaurendo, “sottilmente”, nel corso del ventennio. Vaccari, in ogni atto ha sentito di porre diversi segni intertestuali per rafforzare l’interpretazione prismatica del tempo e delle emozioni nel corso dell’opera, vestendo gli interpetri con tessuti di satin con ricami in rilievo aigrettes nei capelli, perle e fruscianti frac. Il regista, per le scene affidate ad Alfredo Troisi si è affidato al simbolo dello specchio, che campeggia nel I atto al centro riflettendo la società del tempo e la nostra, metateatro simbolo dell’universalità della musica e del dramma, non lontano da quel Don Giovanni scaligero del 2011 firmato da Robert Carsen, nella sua polivalenza, come visione del mondo e della vita. Un mondo dove l’apparire conta più dell’essere, dove l’amore si riduce a consumo erotico e non a rapporto amoroso, relegante alla solitudine, una Violetta star dei salotti, intrappolata di un mondo di aspettative e pressioni insostenibili, una gabbia, per una donna vulnerabile, piena di insicurezze e desideri inappagati, che la porta alla depressione e alla allucinazione da farmaci, nei momenti di introspezione, in cui si interroga sulla propria identità e sul significato di essere amata e riconosciuta. Gli specchi deformanti, che delimitano i tre spazi in cui si svolge l’opera, incarnano le ansie di Violetta, le sue visioni distorte, riflessi della sua mente che si dibatte in una condizione esistenziale universale: la ricerca di un posto nel mondo e il prezzo da pagare. Un viaggio tra realtà e illusione, in una storia di vulnerabilità e lotta, un tema che risuona fortemente nel nostro tempo, dove l’apparenza spesso nasconde una verità ben più complessa, in cui Violetta diviene l’eterna cercatrice di un senso, di una connessione autentica in un mondo che sembra privilegiarne l’immagine piuttosto che la sostanza. Nel finale il libretto obbliga il regista a far finire Violetta per tisi, per la quale non c’è descrizione reale più perfetta, emotorace, shock e morte. Giandomenico Vaccari fa tornare i fantasmi in un flashback in cui Violetta vede se stessa da bambina, quindi, nelle varie età, sino a far intuire la Callas, con il foulard in testa e gli occhiali. Sul Carnevale parigino piove, tanti i simboli in questa scelta, riferimento ai liquidi che avvolgono il feto nel grembo materno, morte, resurrezione, rigenerazione, la morte-bambina porta via Violetta, che rinascerà nell’Oltre, libera del corpo, come avverrà con la musica, ogni volta che sarà riaperta la partitura de’ La Traviata, fino alla fine dei tempi. Due Violette per questa produzione, entrambe apprezzabili, diverse. La performance di Irina Lungu nel primo atto è stata caratterizzata da una certa tensione, comprensibile in vista dell’impegno della cabaletta, “Sempre libera degg’io”. “Ah fors’è lui che l’anima” è stato il momento migliore del I atto. La sua voce, dal timbro scuro e dalla risonanza calda, ha presentato alcuni acuti che sono risultati freddi, con il mi bemolle finale teso dopo una serie di agilità in una cadenza ridotta all’essenziale. Momento culminante della serata è stato “Addio, del passato bei sogni ridenti”, in cui la Lungu è riuscita ad esprimere una grande intensità emotiva sul filo del suono dell’oboe di Antonio Rufo, che è sembrato anch’egli abbandonarsi al soffio di un’utopia ormai svanita, grazie alla tessitura di questa aria che si adatta perfettamente alla voce della Lungu e alla lettura di Daniel Oren che ha contribuito ad esaltarne la bellezza. Trionfo annunciato per Gilda Fiume, una toccata e fuga la sua, direttamente da Verona dalle prove del Falstaff di Antonio Salieri, in scena dopo un tour de force di una giornata e mezza, praticamente senza prove. Daniel Oren ha scelto lei per far musica per una sola performance “Che un giorno sol durò” (citazione belliniana, questa, che potrebbe essere un suggerimento e un invito per la prossima stagione) e loro due, insieme all’orchestra l’hanno avuta vinta su tutto e tutti. Prestigio del gioco d’emissione, nel chiarire o scurire le vocali, tornire la sillabazione, un di più che risiede, appunto, in un atto di intelligenza, di sensibilità, anche critica, albana d’oro scintillante nella cabaletta “Sempre libera degg’io”, in cui ha cantato gli acuti, mostrando ottime qualità tecniche, da pupilla della Mariella Devia e un timbro piacevole, con quella carica emotiva necessaria per rappresentare appieno il tormento del suo personaggio. Violetta ha da affrontare un secondo atto in duetto con Giorgio Germont. Il baritono Simone Piazzola è sembrato mancare di quella forza espressiva necessaria per interpretare un personaggio complesso come il padre di Alfredo. Sebbene abbia un timbro gradevole, la sua mancanza di nerbo si è fatta sentire, specialmente nei momenti in cui sarebbe richiesta una maggiore intensità emotiva. La sua esecuzione nei passaggi cantabili è risultata a sprazzi più convincente, ma qualche difficoltà di intonazione nel registro acuto, i tentativi di utilizzare legato e mezza voce non felice, hanno limitato la sua performance, privando il personaggio di quella vitalità e dinamicità che sarebbero invece fondamentali in un contesto così drammatico. Un po’ di delusione è venuta da Valentin Dytiuk che ricordiamo giovanissimo quale Rodolfo, un perfetto Nemorino e nelle vesti del Duca di Mantova, ma Alfredo non è ancora suo, si è trovato in grave difficoltà sul registro acuto, nella cabaletta del II atto, “Oh mio rimorso! Oh infamia!”, su quel do, che è stata croce e delizia sin dalla prima, dizione non chiarissima e la recitazione, poi, ha fatto rimanere Alfredo un bamboccione fino alla fine. Alessandra Croce ha dato voce ad una Flora Bervoix dignitosa, come lo è stato il Gastone di Vincenzo Peroni, il barone Duphol di Angelo Nardinocchi e, ancora, un brillante Marchese d’Obigny quello di Costantino Finucci, con, a completare il cast, il dottor Grenvil, Carlo Striuli, l’Annina di Miriam Artiaco, il Giuseppe di Paolo Gloriante e il domestico di Antonio De Rosa. Magistrale e trascinante la direzione di Daniel Oren, alla testa di un’orchestra dominata in assoluto dai legni, due i soli attesi quello del clarinetto di Luigi Pettrone, il ricordo, il coraggio per scrivere e lasciare l’amore (e la vita), un climax emozionalmente creato dalla sua ancia, che poi esploderà nell’Amami Alfredo e quello dell’oboe, introduzione alla consapevolezza della morte e alla speranza di essere eternata nella memoria di qualcuno. Tra la prima e la seconda recita, certo, incomprensioni ce ne sono state diverse, tra buca e palcoscenico, come nella premiere, tra il coro e barone Duphol, banda di palcoscenico fuori tono, volume e tempo, ma Oren ha ritagliato per sé e l’orchestra i preludi, in cui gli strumenti diventano le chiavi della psicologia dei personaggi, entrambi cadenzati dalla cellula della morte, alla ricerca dei silenzi, ove s’asconde la musica. Il Maestro ha sollevato l’orchestra in ondate omogenee e piene di sonorità, possenti, per una lettura scevra da ogni incrostazione, oramai di tradizione. All’inizio del II atto, con la cabaletta di Alfredo abbiamo ascoltato l’intensità di violoncelli e flauti, quale espressione della vergogna e del nervosismo del personaggio, le isterie delle due feste, riflesso di una condizione privatissima, hanno trovato spietato risvolto nelle melanconiche intermittences du coeur degli aliti di Violetta morente, appena spezzati dall’irruzione delle taglienti ventate dell’ottavino, insuperato di Vincenzo Scannapieco, che percorrono, fuori scena, il coro del “bue grasso” di Carnevale. Buona prova del coro, in particolare delle voci femminili, preparato da Francesco Aliberti, che ha valorizzato il quadro centrale del II atto, con anche i danzatori, per le coreografie di Luigi Ferrone, con le étoile ospiti, Alessandro Macario e Giorgia Giammona, che hanno avuto il ruolo di accompagnare ed essere specchio delle visioni, di Violetta. Applausi, diverse chiamate al proscenio, lancio di rose e, qualcuno, sullo svanire della vita, ha versato calde lacrime, poiché la Traviata è un’opera che muore d’amore.