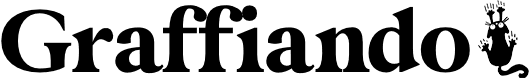Marco Baliani s’immagina buffone gobbo sciancato al trapezio. I virtuosi dell’ aria restano i musicisti Cesare Chiacchiaretta e Giampaolo Bandini. Successo di critica e pubblico in sala Pasolini
di MARIANGELA STANZIONE
In questa “Notte della maledizione”, presentata sul parquet della Sala Pasolini, si vede con l’udito: poche note e già le corde della chitarra issano tendoni, i cui sbuffi parrebbero riecheggiare nel mantice della fisarmonica. L’aria è già gonfia di quella grottesca malinconia tutta circense, quando Rigoletto—la sola biacca sorridente, le lacrime triangolari e il naso rosso a connotarlo entra, claudicante, a dialogare con una musica indifferente, imperterrito sottofondo di una vita di fatiche, passione e miseria. Questi riarrangiamenti da Verdi e dal Nino Rota di Otto e mezzo, unitamente alle composizioni del maestro Cesare Chiacchiaretta fisarmonicista, in duo con il chitarrista Giampaolo Bandini, aizzano in lui eroiche rivendicazioni di dignità di un professionista dell’intrattenimento, anestesista per sovrastimolazione, mentre si prepara al turno di iniezione di colore nell’ennesima grigia periferia. Non rinascimentale buffone, ma vecchio clown post Grande Depressione; non gobbo, ma sciancato da un incidente che determinò (di là dall’interruzione della professione di trapezista) la morte di un’amata moglie, tradita e traditrice: seduto in camerino di fianco a una cassapanca, attraverso un lungo processo di vestizione il protagonista di Baliani riflette su una vita segnata dal nome d’arte sceltosi, rispecchiando la propria nella vicenda del verdiano, tanto rivelandosi a noi quanto più si ammanta del gibboso costume di scena, correlativo oggettivo delle sue sofferenze.
Risentito col pubblico e col caso, deridenti le falle del suo corpo; divorato dagli stessi rimorsi che distrassero la sua presa dal trapezio, nell’ultima fatale esibizione con l’amata; furente col Duca, donnaiolo acrobata in compagnia, cui cosparge di grasso la barra metallica con intenti omicidi per evitare gli porti via Giada, ultimo appiglio affettivo rimastogli—scoprendo troppo tardi ella si esibirà con lui, e reiterando nella sua la sorte della madre. Fulcro del monologo è qui il rapporto intergenerazionale: un padre avvizzito, identificatosi con un inceppato meccanismo di caduta nel privato quanto in scena, e una figlia equilibrista sul filo delle prime volte. Sullo sfondo, un’esperienza dell’affettività e della sessualità cresciuta su un brullo terreno emotivo.
Una riscrittura, questa, che a partire dalla romantica grandiosità operistica intende sapientemente abbassare il tenore al fin di agganciarsi a una sensibilità contemporanea ancora onorando l’affinità per gli ultimi di Hugo, portando la narrazione ad assumere un carattere più esistenzialista, non senza tuttavia occasionali strascichi dal retrogusto decadente, un filo troppo spleen et ideal: la penna di Baliani rimane forse eccessivamente raffinata anche quando dovrebbe sporcarsi nelle reminiscenze delle squallide scopate giovanili con la chiromante, che in quelle mani ancora unte di grasso gli legge forzatamente il futuro di genitore disgraziato; o retoricamente “bambina” nella lettera della diciassettenne, rassicurante espressione più delle lenti con cui i padri in letteratura guardano una figlia, che verosimile autoritratto di un’adolescente. Interessante dunque lo spostamento drammaturgico d’ambientazione; meno efficace l’esecuzione sul finale.
Complessivamente comunque pregiato il gioco di scatole cinesi per cui, dal buffone al clown, dal clown al maestro della narrazione, ci è consegnato il vissuto di un’oscillazione, nell’inerziale calcare le scene, fra slancio verso il cielo e inesorabilità dell’impatto con la terra.