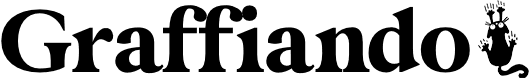Intensa e vera la pièce, “Da lontano. Chiusa sul rimpianto”, scritto da Lucia Calamaro per un’eccellente Isabella Ragonese, ospite del palcoscenico della Sala Pasolini. “Quanti di noi, da piccoli, hanno assistito impotenti ai drammi degli adulti amati Intuivamo, non sapevamo, sospettavamo, non sapendo che fare”
di MARIANGELA STANZIONE
Isabella Ragonese appare silenziosa dal retro. Si osserva intorno, osserva la platea, valutando quanto sta per accadere con grande peso nello sguardo.
Isabella non sembra diversa da Isa, la psicoterapeuta in tailleur azzurro sui quaranta, con tanto di valigetta piena di file: parla con tono affaticato, ma strenuo; dice, semplicemente, “questo è uno spettacolo riparatore”; e dalla serietà quasi parrebbe non si dia finzione in questo “Da lontano. Chiusa sul rimpianto” (scritto da Lucia Calamaro su misura per—e con—Isabella Ragonese). Dove si traccia la linea fra realtà vissuta e realtà scenica? Tra quello che è e quello che non è?
Più che la prima fila di spettatori, una netta linea di separazione la donna l’ha alle spalle: un piatto muro bianco, con una porta sulla sinistra, la schiaccia contro la platea, rispetto a un “di là [che] somiglia a una ventina di anni fa” — un tempo in cui sua madre arrivò ad un’età un po’ minore a quella attuale della protagonista.
“Quanti di noi, da piccoli, hanno assistito impotenti ai drammi degli adulti amati?” si legge nelle note di regia. “Intuivamo, non sapevamo, sospettavamo, non sapendo che fare”. Assistiamo qui al tentativo di una figlia di ricucire uno strappo, aprioristicamente fallimentare perché “non si può rilegare la vita”. Ma una figlia che ha dovuto caricarsi di responsabilità prima del tempo, che proprio alle soglie della vita adulta non le ha rette più, una figlia che ha pensato di potersi concedere una chiamata persa non può darsi pace. Si trova perciò da adulta, avendo fatto del suo trauma professione, incagliata in un meccanismo di sovra compensazione dell’impotenza. Incapace di non “esserci” per i suoi clienti, al telefono, anche alle 5 del mattino. Incapace di definire uno spazio personale. Incapace di dire “no”. “Ascoltare vuol dire rinunciare a parlare”. Eccola, dunque, alle prese col ricordo di una madre in trench verdolino, col sacco di patate da friggere e una busta in testa perché fuori piove, spaesata dalle supposizioni dei vicini sull’Alzheimer; una madre senza strumenti, che per tutto lo spettacolo è poco più che un trapano insistente in quel “di là”; voce stridula e sfuggente, a tratti lagnosa, sempre infantile, in un calzante e dolente ribaltamento di ruoli. Madre che alza muri, madre che chiude porte.
Madre che, contro ogni aspettativa, nel suo ermetismo riesce a costruire finestre. “Ecco, ti ho costruito questa: le cose brutte devi lanciarle via dalla finestra” le si sente dire, in un fuggevole baluginio di saggezza metateatrale.
Da un’assenza martellante quanto lo fu la presenza (all’epoca “sempre con un piede di qua e uno di là”), nello scoprirsi essa stessa paziente nella difficoltà di collaborare, Isa risolve il chiodo fisso che la tormenta—proprio immaginando quella creatura fragile come capace di dare a lei la direzione che non ha saputo venti anni prima trovare per sé. Tra piccoli sprazzi di ironia a controbilanciare un’amarezza generalizzata, e lunghe dissertazioni sulla fenomenologia della carezza, questa scrittura delicata, a tratti aeriforme—con un’attrice che nasconde lacrime (vere?) dietro un stick per ciglia al mentolo—accompagna lo spettatore dentro una storia casalinga, nascosta nell’oggi, fin troppo comune.
Unico neo che si sente di indicare: malgrado la bravura dell’attrice a mantenere il tono dimesso di un personaggio che nel suo quotidiano frequenta Lacan, la drammaturgia si compiace un velo troppo di seminare qui e là, casually, citazioncine colte—si lasci il pubblico libero di ignorare i riferimenti dell’autore, o di eventualmente riconoscerli autonomamente.
Complimenti anche alla tenera voce di Emilia Verginelli.