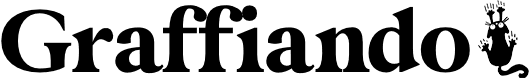di OLGA CHIEFFI
Questa Lucia di Lammermoor, sarà poi proprio, come si assicura, il capolavoro di Gaetano Donizetti nel melodramma serio? Diversamente dalle altre opere del genio bergamasco, comincia molto bene, con un primo atto (più esattamente Prologo) di colorito romantico-scozzese felicemente azzeccato e chiuso da un duo (“Verranno a te sull’aure”) che vanta una delle più belle melodie dell’Ottocento teatrale italiano. Il miracolo si ripete, naturalmente, alla chiusa della partitura con “Tu che a Dio spiegasti l’ali”, che Donizetti non falliva mai e la scena della follia, col dialogo soprano-flauto è per lo meno una grande trovata. Ma in mezzo, nel primo atto dopo il Prologo, ci sta molta paccottiglia. Perfino il celebrato sestetto, che in realtà non è propriamente tale perché sono solo quattro le voci veramente portanti, più interventi del coro, può sembrare una meraviglia di finezze armoniche e di metrica strutturale a chi lo analizzi al microscopio. Ma l’invenzione melodica non è poi sopraffina: un gioiello intagliato da mano di grande artista, ma un gioiello in similoro. Se c’era un’esecuzione da cui si potesse sperare di veder fugati i nostri dubbi, era proprio questa del Teatro San Carlo di Napoli, che partiva come un’operazione destinata a catturare il successo popolare, per un pubblico che l’ama e la conosce, poiché in questo teatro il 26 settembre del 1835 ebbe il suo battesimo. Niente sperimentalismi scenici, niente ambizioni di filosofia, una terzetto di cantanti in carriera, un’orchestra e un direttore quale Carlo Montanaro, comunicativo ed esperto, ma i dubbi sull’opera in sé sono rimasti tutti irrisolti. La porcellana di Capodimonte Nadine Sierra, possiede una voce calda, vigorosa, avvolgente, al cui timbro non manca, quel riflesso cristallino purissimo, unitamente a quel certo che d’infantile, disarmato e indifeso, connesso col metallo stesso di quel tipo di voce che si addice all’innocenza e all’infelicità di eroine romantiche quale è Lucia. Va subito aggiunto che il soprano non ha mai rinunciato al suo splendido sorriso, quasi bamboleggiante che forse si adatta maggiormente alla Giulietta dei Capuleti e Montecchi che alla Lucia, precludendosi così la possibilità di offrire il rilievo tragico nella recitazione. Sul piano strettamente vocale, però, non si è ritratta di fronte a nessuna delle grandi difficoltà della parte, nemmeno a quelle che sono tradizionalmente aggiunte dall’uso teatrale e la rischiosa gara stavolta non si è avuta con lo splendido flauto di Bernard Labiausse nella scena della pazzia, ma con la glass harmonica di Sascha Reckert, che ha riprodotto quell’ “armonia celeste”, mentre la uxoricida Lucia, ha acconciato il suo velo nero a mo’ di pupo, evocazione di una maternità sognata o suo stesso alter ego, considerata e usata quale pedina di scambio sullo scacchiere politico della ribollente Scozia. Questa l’unica “cacciata” del giovane regista di questa ripresa, Michele Sorrentino Mangini, che si è lasciato “intrappolare” dalle scene realizzate, dieci anni or sono per Gianni Amelio da Nicola Rubertelli, popolate dai costumi di Maurizio Millenotti, proponendo una regia praticamente piatta, con personaggi statici, quasi in forma di concerto, riguardo in primis lo schieramento del coro. A fianco della Sierra, il tenore samoano Pene Pati, un dignitoso Sir Edgardo di Ravenswood, in cui abbiamo riconosciuto ottime potenzialità, limpidezza di sillabazione, sincerità di partecipazione espressiva, concedendosi a qualche tentazione di gigioneria, mentre pure è svettata la voce di Gabriele Viviani, il quale è riuscito a dare molto rilievo al ruolo di Lord Enrico Ashton, che è piuttosto ingrato, lasciando risaltare a pieno l’esuberanza dei suoi mezzi vocali, avvantaggiato dall’assenza di toni crepuscolari nella lettura dell’opera impressa da Carlo Montanaro. Dario Russo nei panni di Raimondo e Daniele Lettieri, impegnato nella parte di Lord Arturo Bucklaw, con qualche ombra,Tonia Langella in Alisa e il comprimario di lusso Carlo Bosi nel ruolo di Normanno, sono riusciti ad offrire ottimo sostegno ai giovani protagonisti, unitamente al coro, preparato da José Luis Basso, presente anche scenicamente nel quadro delle nozze che si è avvalso delle filologiche coreografie di Stéphane Fournial, pensate per il corpo di ballo del teatro. Non possiamo, però, parlare di proprietà stilistica estesa all’intera partitura, da parte di Carlo Montanaro, il quale si è ritrovato in diversi punti con qualche “interruzione” di comunicazione tra palco e golfo mistico, non riuscendo ad evitare eruzioni di enfasi canora, in particolare nel soprano, ancora attanagliata da certa giovanile urgenza espressiva, né offrendo quella sobrietà di mezze tinte, di certi squisiti colori a pastello, che pur segnano l’appassionato abbandono del sentimentalismo donizettiano: Montanaro non ha agito con la tecnica precisa del mosaico, ponendo in ogni punto il giusto tono di colore che ci vuole, ma con la tecnica focosa di un pennello supportato da una tavolozza dai colori sgargianti, adatti certamente al terzetto, ma non alle penombre dello spartito e in particolare sottese dalla regia. D’altra parte anche l’orchestra non ha offerto una delle sue migliori prove, in particolare l’arpista chiamata a quel solo dell’introduzione a “Regnava nel silenzio”, emozionalmente dedicata da tutti, ad Antonella Valenti, la sublime prima arpa triestina, solo da qualche giorno prematuramente scomparsa. In contrasto, infatti, è risultata per intero l’esecuzione con le scenografie, improntate ad un criterio di sobrietà, ideate compiacendosi, in effetti un po’ statici di rievocazioni di incisioni del tempo, con una sistematica carenza di mobili e suppellettili in scena, con i cantanti sempre in piedi. Applausi in un teatro non tutto esaurito, nonostante l’accorpamento delle prime due repliche, in particolare per i due protagonisti.